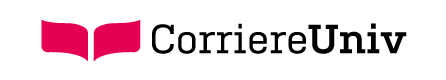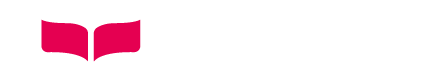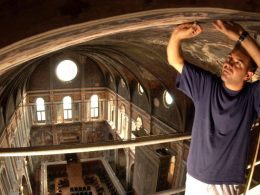A volte fa strano pensare che il settore informatico, ora così centrale nelle nostre vite, lavorative e non, sia nato pochi decenni fa. I pionieri dell’informatica erano matematici o ingegneri elettronici, le facoltà relative non esistevano ancora quando nacquero i primi pc. In Italia, il primo corso di laurea aprì nel 1991 e il primo laureato in ingegneria informatica fu Francesco Buccafurri, ora professore di cybersicurezza all’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Inizialmente si era iscritto a Ingegneria Industriale, ma cambiò corso a esami finiti perché il nuovo indirizzo era appena stato aperto. Oggi, Buccafurri è membro del ministero dell’Università per la definizione del Programma nazionale di ricerca. Il Corriere dell’Università lo ha intervistato per parlare di come è cambiato l’insegnamento e l’apprendimento di questa scienza.
Cosa la spinse a passare da ingegneria industriale a ingegneria informatica?
Certamente l’arrivo presso UNICAL di alcuni docenti, in particolare del Prof. Saccà, la loro capacità di trasferire la passione verso l’informatica ma anche di far comprendere che l’informatica avrebbe rappresentato il futuro, sono stati alla base della mia decisione. Ma non fu solo una scelta basata su aspetti strategici. L’informatica catturò il mio interesse. Mi resi conto che, nel panorama delle discipline tecnologiche, l’informatica è l’unica disciplina con spessore e profondità concettuale e teorica. Non mi riferisco al fatto che, come avviene in altre discipline ingegneristiche, altre discipline di base, come la matematica e la fisica, sono alla base della tecnologia in questione, ma che l’informatica stessa, a partire dalle sue origini (la teoria della calcolabilità e gli studi di Alan Turing) opera anche a un livello teorico e concettuale applicabile in diversi campi, il livello del pensiero computazionale. Questo, a mio avviso, conferisce all’informatica un fascino unico, connesso al suo ruolo pervasivo, sia nei processi cognitivi sia in quelli produttivi della società dell’informazione. Oggi insegno e la mia esperienza quotidiana, il costante contatto con il mondo del lavoro e quindi delle principali aziende di It del panorama nazionale e internazionale, mi permette di affermare che l’informatica sempre più consolida nel tempo il suo ruolo cruciale nello sviluppo della società, che si traduce in una fortissima domanda, da parte del mondo del lavoro, di competenze di questo tipo.
Quali linguaggi di programmazione aveva studiato all’epoca?
Iniziai con il Pascal, poi ebbi modo di conoscere diversi linguaggi, come Modula 2, oppure il pioneristico linguaggio Ada, conoscenza ancora molto preziosa in diversi ambiti industriale, poi C, a cui ben presto seguì C++. Ebbi anche modo di conoscere Smalltalk, un altro esempio di fuga in avanti, un linguaggio molto moderno per quei tempi, perché anticipava il paradigma objectoriented in maniera forse più pura dei linguaggi objectoriented che successivamente si sono affermati (C++, Java, etc.). Ma il linguaggio che mi attrasse di più fu certamente Prolog, il principale rappresentante del paradigma di programmazione logica. Un modo di programmare completamente diverso dalla programmazione imperativa, più vicino ai linguaggi funzionali, orientato a codificare cosa si vuole ottenere con il programma, rispetto a come farlo. La tesi riguardò la programmazione logica, così come i miei primi anni di ricerca scientifica.
Come preparò la sua tesi in un mondo senza internet?
Se penso a come siamo abituati a lavorare oggi, alla velocità con la quale riusciamo a reperire informazioni, articoli scientifici, a connetterci con colleghi o eventi, ho la sensazione che senza internet non fosse possibile lavorare. In realtà quando sviluppai la tesi, in ambito universitario e di ricerca internet era già in uso. Le email si usavano correntemente e il web era neonato. Però è come se oggi fossimo in una Ferrari e a quei tempi su un monopattino. E la disponibilità di fonti era infinitamente più piccola rispetto ad oggi. Per cui, avevamo qualche difficoltà in più, le biblioteche erano più frequentate, la produttività era certamente minore. Qualche anno dopo la laurea trascorsi un periodo di studi e ricerche presso l’Università politecnica di Vienna. Ricordo come la biblioteca multipiano dell’Università, dove vi era disponibilità di tutti i proceeding di conferenze e le riviste scientifiche, fosse un luogo che frequentavo quotidianamente. Quello che oggi facciamo con un click su Google scholar, a quei tempi costava tempo e fatica. Ma anche questo aveva un fascino. C’era sempre un connotato esplorativo nell’attività di ricerca, con percezioni fisiche oggi scomparse.
Che prospettive poteva dare studiare informatica all’inizio degli anni ’90?
Si iniziava ad intuire che di li a poco l’informatica avrebbe aperto diverse strade al futuro di un giovane neolaureato. Già gli annunci che le aziende pubblicavano sui giornali (a quei tempi il job posting su Linkedin non esisteva) davano un chiaro segnale di netta prevalenza sulle altre discipline dell’ingegneria. Stessa chiara consapevolezza si poteva ricavare dalla partecipazione ai careerday presso le università. Io stesso, prima di scegliere di svolgere la tesi presso l’Ateneo, venni contattato da una prestigiosa azienda multinazionale che opera nel settore dei beni di consumo, che doveva realizzare la propria divisione IT ex novo, e quindi era alla ricerca di ingegneri informatici. Il colloquio andò bene, ma alla fine scelsi la ricerca, e non me ne pento affatto, perché era la mia passione.
Come sono cambiati i corsi d’informatica di allora? Ci sono ancora delle cose in comune?
I fondamenti scientifici della materia rimangono uguali nel tempo, con le evoluzioni che la ricerca scientifica apporta nel corso degli anni. La tecnologia si è evoluta molto, per cui oggi vi sono molte materie che a quei tempi non potevano esistere. E’ importante però sottolineare un aspetto dal punto di vista formativo. Mentre nel passato l’informatica poteva essere vista come una tecnologia stand-alone, l’ingegnere informatico dei nostri tempi (e questo sarà sempre più vero) deve sempre più confrontarsi con altri ambiti delle discipline tecnologiche (come le reti di computer, i dispostivi, etc.). Questo deriva dall’assottigliarsi del confine virtuale-fisico che l’evoluzione tecnologica sta determinando. Mondo virtuale e fisico si confondono, e gli oggetti fisici sono oggetti virtuali. Ben vengano quindi programmi di formazione multidisciplinari. Ad esempio, presso l’Università dove insegno, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, trovo molto formativo il corso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica e dei Sistemi per le Telecomunicazioni nel quale sono principalmente impegnato. Dare agli studenti la capacità di operare trasversalmente è esattamente quello che l’attuale tecnologia richiede.
Come ha proseguito la sua formazione e perché ha puntato sulla cybersicurezza?
Dopo la laurea iniziai subito ad impegnarmi nella direzione della carriera accademica, con borse di studio, dottorato di ricerca, incarichi di insegnamento, periodo di visiting presso l’Università Politecnica di Vienna, fino al concorso per ricercatore presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nel 1997, Università nella quale ho compiuto i successivi passi di carriera (Professore Associato nel 2002 e Professore Ordinario nel 2005). Ho iniziato ad interessarmi di cybersecurity ben presto, durante gli anni di dottorato. L’interesse venne alimentato dall’avvio con una collaborazione con l’Università di Milano, e andò via via crescendo, fino a diventare il mio principale ambito di ricerca. Principalmente una questione di passione, quindi, basata sulla consapevolezza che la cultura della security fornisce una visione non convenzionale, fortemente critica, creativa, ma estremamente rigorosa.
Come devono specializzarsi gli studenti di informatica ora che i linguaggi base, come html, sono entrati nella vita di molte persone?
Le tecnologie web, così come quelle cloud, continuano ad essere molto importanti. Oggi però ci sono diversi ambiti verso i quali è opportuno approfondire le proprie conoscenze. Tra questi vi è certamente la cybersecurity, ambito nel quale c’è un elevato gap di competenze al livello globale. La sicurezza informatica è un problema che riguarda singoli individui, organizzazioni pubbliche e private, interi stati. Non vi è dubbio che anche l’Intelligenza Artificiale (AI) rappresenta una nuova frontiera che inciderà significativamente nell’evoluzione tecnologica dei prossimi anni. Ma vi è una forte connessione tra i due campi. Non solo perché l’intelligenza artificiale può essere un’ottima alleata della cybersecurity in diverse aree di intervento, ma anche perché i sistemi autonomi basati su AI sono spesso critici, nel senso che azioni ostili finalizzate a deviarne il comportamento, possono avere conseguenze rilevanti, talvolta anche lesive dell’incolumità delle persone e dell’ambiente. Cybersecurity, nella sua accezione più ampia, che include anche tecnologie abilitanti come blockchain, e Intelligenza Artificiale, sono quindi certamente le principali direzioni di sviluppo dei prossimi anni.
Come componente della commissione del ministero dell’Università per la definizione del Pnr, come vede la situazione italiana sulla ricerca informatica e sull’intelligenza artificiale? Cosa ci manca?
Dal punto di vista della ricerca l’Italia ha un’ottima collocazione nel panorama internazionale nel settore dell’informatica, in generale, e dell’Intelligenza Artificiale, in particolare. Ciò che penalizza il sistema italiano della ricerca è certamente l’insufficienza del finanziamento pubblico, ma soprattutto le politiche che non favoriscono adeguatamente l’ingresso dei giovani nelle carriere di ricerca. Occorre incrementare l’impegno pubblico a favore dell’Università e della Ricerca mantenendo una netta distanza da derive culturali che tendono a far crescere il divario tra nord e sud del paese o, all’interno del sistema universitario, tra grandi Atenei e medio-piccoli. Sarebbe una pericolosa anacronistica involuzione.