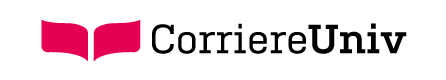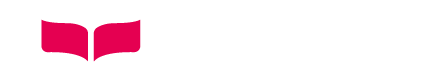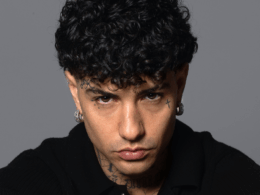Prima di “Mio nonno era comunista”, Monica Granchi aveva pubblicato un altro romanzo intitolato “Il Mercante”, un vero e proprio romanzo di cappa e spada, usando le parole di Antonio Tabucchi. L’autrice aveva preferito un esordio letterario ”di genere” proprio per gli schemi rigidi che esso impone. Con la sua seconda prova letteraria, però, la Granchi spiazza i lettori con un’inversione di rotta verso un romanzo tanto più difficile da “inquadrare” (è un romanzo storico? autobiografico? psicoanalitico?) quanto più autentico ed interessante. La vena romanzesca di “Mio nonno era comunista”, infatti, sembra talvolta competere con la primigenia vocazione di questo libro, quella di piccolo saggio politico: effettivamente, parlando della genesi del proprio romanzo, Monica Granchi ha più volte spiegato che il racconto ha avuto origine dal suo bisogno di riflettere sul passato della sinistra, per provare ad immaginarne le prospettive future. Naturalmente il perno attorno cui ruota la narrazione è proprio il nonno, da cui il libro prende il titolo e da cui la piccola Monica prende un naso che la rende un’adolescente insicura. Ma, insieme al naso, la nipote eredita anche uno spiccato senso dell’ironia, la passione per la musica, il cinema, la letteratura e soprattutto un’idea di sinistra che tutt’ora sopravvive in lei grazie alla figura del nonno. Ed è nel tentativo di trasmettere questo ideale di sinistra anche a chi non l’ha vissuto, di mostrare cosa davvero significasse sentirsi parte di quella comunità, che Monica Granchi decide di scrivere il suo secondo libro.
Eppure al lettore sembra ben presto che le intenzioni storiche e politiche vengano messe in secondo piano da una narrazione che sfugge alle regole, e forse all’autrice stessa, in un flusso di coscienza inarrestabile che procede per libere associazioni di idee ed immagini. In effetti, chiunque parli o scriva qualcosa a proposito di “Mio nonno era comunista” deve subito rilevarne una caratteristica: è un libro che va letto tutto d’un fiato. Ma l’espressione, ormai logorata dall’uso, non rende più con concretezza quella sensazione che dovrebbe esprimere: l’urgenza di non poter chiudere il libro fino alla fine. Il perché di tale urgenza è evidente già dalle prime pagine: l’incessante accumulo di frasi, di pensieri, che si accavallano e scorrono come in una seduta psicanalitica, non è diviso in capitoli né in paragrafi. Tutto si tiene. Ed i numerosi punti che spezzano il flusso di coscienza, rimettendo (poco) ordine nel caos, hanno perso l’originaria funzione di separazione logica e sintattica per diventare, al contrario, veri e propri “punti di sutura” tra una frase e l’altra, a tenere insieme gli strappi di un’adolescenza solo apparentemente come le altre ma che in realtà è segnata dalla drammatica esperienza dell’anoressia.
“Mi sono ammalata di anoressia intorno ai sedici anni.”: è con questa dichiarazione che Monica Granchi inizia a raccontare la propria storia, quasi si trattasse di una premessa senza la quale il senso del romanzo non potrebbe essere compreso appieno, un invito a prestare attenzione al fatto che “Mio nonno era comunista” non è solo una storia di ideali e di ricordi, ma anche di un corpo; un corpo femminile e fragile, quasi inconsistente ma che nonostante questo, anzi proprio tramite tali privazioni, reclama attenzione ed affetto. E questo paradosso si ritrova nell’espressione con cui Monica Granchi descrive la malattia: “un’aura che richiama attenzione ma respinge il contatto”, espressione che ben sintetizza quel rapporto difficile con gli altri, con l’alterità stessa che la propria immagine riflessa nello specchio rappresenta. Nelle sue accurate analisi davanti allo specchio, nei tentativi disperati, nelle improbabili soluzioni chirurgiche, sembra di scorgere una moderna Alice; la protagonista del delirante racconto di Carrol, a causa delle continue metamorfosi cui è sottoposto il suo corpo di bambina, si domanda: “E se mi avessero scambiata stanotte? Vediamo un po’: stamattina, quando mi sono svegliata, ero proprio la stessa? Mi sembra di ricordare che un po’ diversa mi sentivo, sotto sotto.”
Monica, a sedici anni, è altrettanto perplessa e sospettosa riguardo a quel corpo che vede riflesso nello specchio ma che non riconosce più come proprio, e nei confronti del quale si sente quasi “un alieno cattivo entrato in un corpo non suo”. E’ un’immagine che lascia un po’ sgomenti: Hollywood non ci ha certo abituati a considerare il punto di vista dell’alieno. Ma questo non è nemmeno il giudizio più severo a cui la scrittrice senese si sottopone: nel corso del romanzo troviamo un’incessante autocritica al proprio aspetto, come abbiamo già detto, ma anche al proprio carattere ed atteggiamento, a volte insicuro, altre competitivo, egocentrico o persino snob. Grazie ai “punti di sutura” con cui ricuce tra loro i pensieri, Monica Granchi lascia senza respiro il lettore e non concede pause nemmeno a se stessa, nel corso di questa spietata autoanalisi: come per togliersi un peso. E’ vero che, dietro pagine dal tono spontaneo, si nasconde talvolta il più sofferto lavoro di limatura, tra ripensamenti e cancellature. La densità di questa prosa, il suo ritmo serrato, ci fanno intuire la fatica spesa dietro la scelta di ogni vocabolo ma ciò nonostante, leggendo quel flusso travolgente che è “Mio nonno era comunista”, è difficile pensare che non sia nato già nella sua forma definitiva, pagina dopo pagina, come un diario o, meglio, come una confessione a lungo rimandata. Si tratta, in definitiva, di un libro molto, troppo personale, in cui persino il discorso politico passa attraverso la figura privata del nonno. E viceversa, attraverso le trasformazioni e le sofferenze di quel corpo di “donna invisibile”, è possibile scorgere la storia di mille altri corpi, corpi femminili o corpi adolescenziali, corpi che si sentono feriti, incompleti, rifiutati. Per questi corpi, e per gli “alieni” che li occupano, le parole di Monica Granchi rappresentano non una richiesta d’aiuto, ma una possibile soluzione: una voce alternativa a quella silenziosa e devastante dell’anoressia; un piccolo ma indispensabile punto di sutura per gli strappi dell’anima.
Flora Ciccarelli